Narrativa
da "Renato e i Giacobini"*
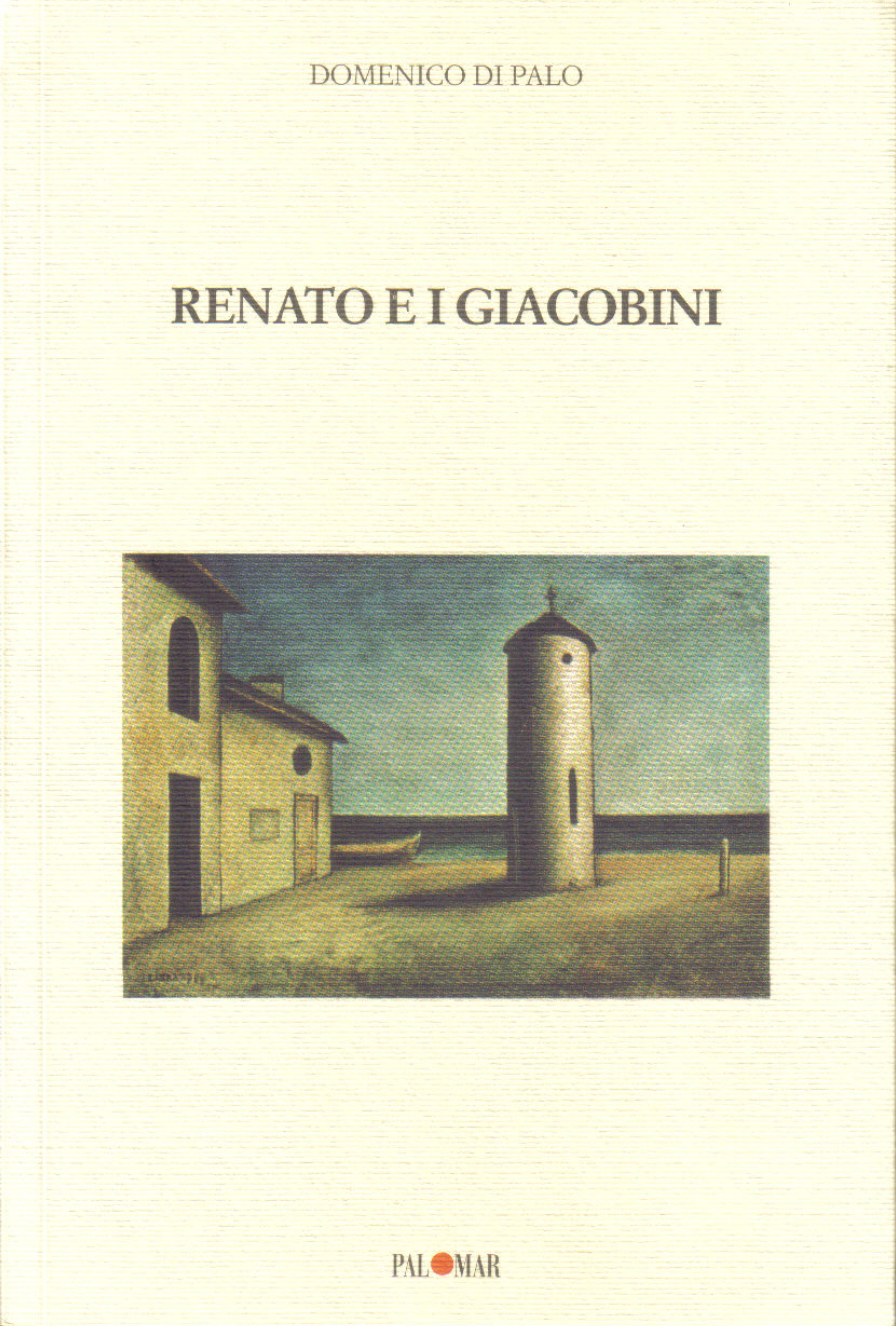
ROMANZI E CITTÀ
Così ho deciso: scriverò un romanzo, un lungo racconto in cui la realtà sia mescolata alla fantasia, una storia con un principio ed una fine, con un lui una lei e gli altri a fargli da cornice. E poi con i grandi temi universali, il personale e il politico, il pubblico e il privato, il singolare e il plurale, l’amore e il disamore, la vita e la morte…
E certo la capacità non mi manca, né il tempo, visto che ormai passo le giornate a sorbirmi, pancia all’aria, tutto ciò che danno in tv, o a scandire le attese tra le faccende domestiche e comunque non particolarmente gravose per la mia consumata abilità a trasformare ogni cosa in routine.
Ed eccoli, i pochi che ancora mi frequentano, quelli che amano la mia natura d’istrione, ad insistere che finalmente mi dia da fare. “Che cosa aspetti - mi dicono - Su, facci godere e lasciaci un segno duraturo del tuo glorioso passaggio nella storia di noi mortali…”.
Così dunque ho deciso: scriverò un romanzo, denso complesso ed ovviamente con il suo messaggio ambiguo, perché - si sa - l’ambiguità è tutto. Poi lo spedirò ad un editore e senza curarmene troppo aspetterò una risposta, che non tarderà a giungermi, entusiasta e sbrodolona…. Ma questo è secondario.
Sì, l’idea è buona: bisogna soltanto darle corpo. E ad una condizione: devo parlare di me, del mio stato di privilegiato, di me geniale e superiore… E il romanzo potrebbe avere come titolo. “Storia di Renato e dei giacobini”, dove Renato naturalmente sono io e i giacobini gli amici che un tempo mi giravano intorno.…
No, meglio per ora lasciar perdere il titolo. Meglio insistere sull’idea iniziale, quella che mi ha suggerito Rinaldo, quella sera d’ottobre in cui lui dice di avermi incontrato per caso.
“Sai, Renato…” mi ha detto tra l’altro Rinaldo.
Rinaldo, un po’ come tutti gli altri, è scappato da Trani quand’era disponibile a tutto pur di sopravvivere. Ora che si è sistemato in Germania lui dice che si barcamena. Ed è contento.
“Sai, scendo a Milano e prendo contatti con la casa editrice Adelphi (scommetto che nella tua libreria ci sono tutti gli Adelphi…). A Milano m’incontro con Lalla Romano (la Romano a Milano); a Bologna vado da Roversi… Parliamo di tutto: si respira cultura europea. Poi, appena sceso quaggiù, il silenzio. Qui non succede niente. E’ una vera schifezza!… Per fortuna ci sei tu, unico punto di riferimento per tutti noi emigrati nel mondo”.
E quindi una raffica di parole sui centri storici del Sud (“i più belli d’Europa”) che decadono perché “non ci si trasferisce con armi e bagagli” ma si lasciano a chi vi ricicla, aprendo pub e ristoranti, denaro sporco, il denaro ricavato dal contrabbando e certamente dal traffico di droga; sul ruolo egemone della nuova classe media; sul moralismo che blocca; sul-l’ostinata e sterile vocazione illuministica dei “meridionalisti in ritardo”, una vocazione che - ha sentenziato - impedisce di fare i conti con la nuova cultura europea; su certi “provinciali accanimenti” (testuale) contro questo o quell’altro piccolo boss della città (“Ma cosa credono che conti Tizio o Caio!”); sull’essere spiazzati rispetto al dibattito attuale; sul peso del marco tedesco; sul fatto persino che si comincia ad esagerare sul fenomeno dei na-ziskin, sui rigurgiti di razzismo e così via.
E’ fatto così Rinaldo, né da quando si barcamena ha cambiato natura. Per questo mi mette allegria. Ma quella volta mi ha divertito ancora di più. E mi ha fatto davvero bene il suo gusto dell’iperbole, la sua idea di questa società meridionale.
Così sono stato lì sul punto di rispondergli: “Bravo, tu sì che sai vivere e capisci il mondo…” eccetera eccetera…
E, quando mi sono sorpreso a pensare al sapore anche tutto letterario delle sue parole, mi è persino venuta una voglia di abbracciarlo….
“Finiranno ancora una volta - ha insistito Rinaldo con la sua aggiornata filosofia della vita - col mordersi la coda… Non hanno capito un cazzo! Ma escano, una buona volta, da questa tana! che girino il mondo! La storia va avanti e qui non succede mai niente!… Per te è diverso, lo so, e tenuto conto che non hai più vent’anni, devo riconoscere che il tuo sforzo creativo è straordinario. Ti vedo più in forma del solito. Perché non scrivi un ro-manzo?”
E’ finita così la nostra chiacchierata, ed io, gratificato da questa giusta os-servazione sul mio stato di grazia, me ne sono tornato a casa.
Sì, scriverò un romanzo. E prendendo spunto proprio dalla frase che mi ha ricordato Rinaldo: “Più si va avanti negli anni e più è difficile divertirsi.”
A sentire il mio vecchio amico, queste parole le avrei dette proprio io quand’ero ancora un giovanotto. E Rinaldo, unico testimone di quell’evento miracoloso le ha colte al volo e archiviate per sempre nella sua memoria, per trasmetterle ai posteri naturalmente, come Platone con Socrate, ha ag-giunto. Poi se n’è andato per l’Europa, come tutti gli altri, come Natale, come Giovanni, come Alberto e tanti altri che ormai non ricordo più. Ed io, il migliore del gruppo, sono rimasto solo, senza nemmeno più qualcuno con il quale discutere o cui confessare, oggi, il mio problema sul romanzo da scrivere, o con cui spartire, ieri, la mia inutile crociata contro l’imbecillità u-mana, le mie battaglie perdute contro le miserie degli uomini, e contro i fur-bi e i furbastri, i politicanti di tutte le bandiere.
Un giornalista piemontese ha scritto di recente che dal Mezzogiorno d’Italia emigrava soltanto la borghesia imprenditrice; quelli che restavano invece erano un po’ tutti dei “borghesi lazzaroni”, avidi di sovvenzioni e di piccoli favori.
A me dà ancora fastidio sentir parlare del Sud in questi termini: io so che gli amici andati via in genere hanno fatto fatica a sistemarsi. Qualcuno, certo, è stato più fortunato. Ma si è trattato di un caso e poi, per quanto mi riguarda, ho passato la vita a fare il bastian contrario nel conformismo dilagante…
Ma forse, forse il piemontese ha ragione.
Chi può negare, infatti, che quaggiù si continua a vivere nella mediocrità e nell’ingordigia. Che quaggiù è tutto merda. E cosa hanno fatto realmente i giovani che sono rimasti? Che ascolto ha avuto la voce di quei pochi che, come me, si sono dati da fare per tanti anni per cambiare un po’ le cose?
Ho sputato anche per aria quando mi sono dato da fare, e quando l’impegno politico non era ancora di moda. E con quali risultati? Meglio non par-larne…
Ed è stato così che, un giorno dopo l’altro, mi sono sentito sempre più come un profeta disarmato, un don Chisciotte contro i mulini al vento, fino a ri-durmi a parlarmi addosso e a condividere, senza più riserve, quel vecchio detto popolare per il quale ognuno ha proprio quello che si merita, co-minciando da chi deve governare e finendo al frutto stesso di questo governo (che è ben altra cosa, si sa, dell’invenzione manganelliana dei sud-diti essenziali al concetto, alla definizione della regalità, o dell’altrettanta scontata equazione del cacciatore e della preda).
E’ vero - come qualche volta generosamente mi ricorda Rinaldo - che non sarei quello che sono se non fossi stato quello che sono stato. Ma chi sono? Certamente uno che oggi teorizza il romanzo da scrivere.
Questa è dunque la realtà, e con questa realtà bisogna fare i conti.
Ma per questo non è
proprio il caso di scomodare un giornalista piemontese, il quale,
pertanto, ha davvero scoperto l’acqua calda quando scrive
quello che scrive.
AMICI E CIRCOSTANZE
Scatta a volte nella mente un meccanismo strano per il quale alcuni luoghi o persone si associano fatalmente a particolari fatti o episodi, siano pure questi banali o comunque non particolarmente significativi. Sarà per un profumo, un gesto o chissà cos’altro che si è sepolto per sempre nella tua coscienza, ma questi fatti ed episodi riaffiorano puntualmente (e spesso senza volerlo, ha aggiunto Rinaldo citando Proust) nella memoria ogni volta che ritorni ai luoghi a cui sono collegati, e di questi diventano per così dire l’emblema.
Così, per esempio, è per la penisola di Colonna, dove pure io ho vissuto al-tre mille esperienze, certamente più importanti; ma è ad una notte d’estate del 1960, una notte di oltre venti anni fa, che mi sorprendo a pensare ogni volta che si parla di Colonna. Una notte da vitelloni felliniani, come tante già trascorse in quegli anni, girando a vuoto per la città, andando qualche volta a puttane, parlando a profusione di Kafka o di Hemingway (su cui sapevamo tutto) ed anche di Pavese, e accomiatandoci all’alba, Rinaldo ed io, con un saluto ibseniano, che ormai s’era fatto rituale: “Buona notte, Gian Gabriele”. “Buona notte”.
A quel tempo con noi c’era anche Luigi, un buontempone allampanato che stava lì ad assorbire come una spugna le cattedrali d’idee che, notte dopo notte, Rinaldo ed io costruivamo sulle nostre letture, sulla nostra esistenza, sulle nostre alienazioni.
Fu quella, teorizzai dopo, la fase estetica della mia vita.
Io avevo già pubblicato presso un piccolo editore milanese una raccolta di versi e quindi per tutti ero ormai “il poeta”; Rinaldo definiva i suoi interessi letterari; e Luigi, già avvocato e comunque il più inserito di tutti del gruppo, che ci faceva da platea entusiasta. E, infatti, ci ascoltava quasi in religioso silenzio e si beava da matto nel sentirci parlare, perché - diceva - infilando una dopo l’altra, nella sua prossima occasione mondana o anche nei corridoi del Tribunale, tutte le nostre architetture dialettiche sì che avrebbe fatto una bella figura.
Fu Luigi, una volta, ad organizzare con Rinaldo, da gran burlone qual era, uno scherzo feroce.
Leggevo allora le poesie di Cardarelli, che avevo trovato in una vecchia edizione dello Specchio di Mondadori su una bancarella di Milano, e le re-citavo agli amici, sinceramente affascinato non solo dalla rotondità dello stile ma anche dal mistero - dicevo con Rinaldo - tutto letterario, e comun-que sempre suggestivo, presente in alcuni testi del poeta “etrusco”. Naturalmente, in quei miei frequenti saggi di capacità interpretativa non mancava la poesia sui gabbiani, quella di “Non so dove i gabbiani abbiano il nido/ ove trovino pace./ Io son come loro,/ in perpetuo volo…”.
Mi accingevo dunque una sera ad uscire di casa, da dove Rinaldo era passato a prelevarmi, per incontrarci come il solito con Luigi, quando per mezzo di un ragazzo che aveva tutta l’aria di un fattorino mi viene re-capitato un pacco confezionato a dovere. Lo apro subito curiosissimo lì da-vanti a Rinaldo, che mostrava altrettanta curiosità, e in verità con non poca fatica per l’ansia che improvvisamente mi aveva preso. E cosa vi trovo dentro? Un gabbiano, sì un grosso gabbiano morto.
Senza fare parola richiudo il pacco e, pensando naturalmente a Luigi, insieme a Rinaldo che stava lì per esplodere, mi reco all’appuntamento.
Luigi ci aspettava, insieme ad
altri amici convocati per l’occasione, su una banchina del
porto. Io non lo saluto nemmeno e, salito sulla banchina, con un gesto
solenne butto a mare il pacco con tutto il suo macabro contenuto. Non
senza però aver pronunciato, in una fragorosa e liberatoria
risata di tutti i presenti, quella frase che per anni Rinaldo e Luigi
mi hanno ripetuto ogni volta che si è pensato a quei tempi:
“Adesso io so dove i gabbiani hanno il nido, ma voi siete
delle troie”.
Eh sì, fu davvero diversa la mia prima esperienza politica, quella vissuta con gli amici, con Rinaldo, con Alberto, con Natale, con Giuseppe, con Do-nato… e tutta esaurita con essi, perché dopo ognuno di noi se ne andò per la sua strada. E diversa, forse perché allora non mi pesava la solitudine, o perché eravamo ancora capaci, pure nell’urto quotidiano con la realtà (così si diceva), di vivere con allegria.
I primi anni sessanta, dunque, il governo Tambroni, l’affronto del congresso missino a Genova, medaglia d’oro della Resistenza, i moti di piazza e i morti di Reggio Emilia e in Sicilia.
Ce n’era abbastanza, insomma, per sentirci motivati a rompere una volta per tutte con un passato di vitelloni e comunque già in crisi di certezze, anche per le chiusure bigotte alle iniziative culturali che cercavamo di promuovere nella noia cittadina. Come il circolo del cinema, ad esempio, il primo ad es-sere fondato in città.
Già, il circolo del cinema! Con i nostri autori preferiti, e quei film che sono rimasti per sempre nella memoria.
Ma quante difficoltà, quanti problemi furono legati a quell’eroico progetto e quali censure, che ostracismo feroce certi preti e certi notabili, per i quali persino discutere di cinema era sovversivo, misero in atto contro di noi, e con il risultato non solo di rafforzare la nostra amicizia ma col farci sentire ancora più “rivoluzionari”, fieramente votati ad una causa giusta e per la quale eravamo pronti a qualsiasi sacrificio.
Che stagione eroica fu quella! In televisione si dava allora il dramma di Federico Zardi “I giacobini”. Infiammati da sacro fuoco non ne perdevamo una puntata in casa di Rinaldo, ed era naturale per tutti noi immedesimarci in Robespierre e in St. Just, del quale sapevamo a memoria il discorso alla Convenzione (“Si è tentato di persuadervi che il Re è inviolabile…”) che, un po’ per celia e un po’ per non morire, a turno e con tutta la determinazione che avevamo in corpo, declamavamo nelle occasioni più impensabili, oltremodo felici naturalmente, come si diceva in quegli anni, d’épater le bourgeois.
Il più bravo di tutti in queste esibizioni era Natale, l’esperto per eccellenza di cinema e persino poliglotta.
Allampanato, eternamente malinconico e capace all’improvviso di lazzi go-liardici, battute spiritosissime e trovate surreali alla Groucho Marx, di cui era entusiasta, Natale, o Natalino, come ci piaceva chiamarlo, era l’a-nimatore degli immancabili dibattiti alla fine di ogni proiezione. Suo era anche il compito di preparare le schede dei film in programma. Un po’ si compiaceva, Natalino, di questa sua dottrina e tutti noi stavamo al gioco, a volte provocandolo a sfoggiare la sua cultura cinematografica, a volte can-zonandolo o invitandolo bruscamente ad essere più conciso nelle sue re-lazioni verbali. Terminate le quali Natalino s’immusoniva come il solito e non c’era più modo di farlo parlare. Poi, a tarda sera, eccolo d’un tratto salire su uno dei tavolini del bar della piazza, il “Tre palme”, a quel tempo non ancora frequentato dai drogati e dove mi recavo puntualmente per rivedermi con gli amici, ed eccolo Natalino, che non sopportava più di una birra, cominciare ad arringarci con quanto fiato aveva in gola, in italiano prima, poi in inglese, poi in spagnolo e quindi, ovviamente, in francese: “Si è tentato di persuadervi che il Re è inviolabile, o che dovrebbe essere processato come un semplice cittadino. Io dico che deve essere giudicato come un nemico, che noi dobbiamo combatterlo più che giudicarlo…”.
Gli applausi scrosciavano, i rari passanti lo guardavano sbigottiti, dandogli naturalmente del matto, e noi lì a ridere tenendoci la pancia.
Il repertorio di Natalino, tuttavia, era vastissimo: Shakespeare, l’imman-cabile Garcia Lorca, Maiakovski, i “Canti cubani” di Nicolas Guillen (”Mayombe – bombe – mayombe!/ Sensemayà, la culebra…”), che ci impegnavano in un frenetico accompagnamento ritmico con posate, bic-chieri e pugni sui tavoli, i poeti d’Algeria in lotta per l’indipendenza na-zionale... E poi la musica barocca.
“Dalla Camerata dei Bardi, vi trasmettiamo: ‘Perì l’amore mio’, coro per quattro voci e due orchestre”.
“Perì l’amore mio/ e solo mi lasciò./ Si pasce il cuor d’ambascia/ il mio trafitto cuor./ Vorrei anch’io perire/ per non soffrire più…”.
“Perì l’amor/ perì l’amor/… Si pasce il cuor/ si pasce il cuor…”
Nel grigiore della vita di provincia era molto facile intanto essere catalogati come “gli intellettuali”, gli stravaganti che perdevano tempo in chiacchiere e discussioni inutili.
Ma quando cominciammo a sviluppare iniziative concrete, una decisa o-stilità si creò nei nostri confronti, e la nostra festa finì.
Gli iscritti cominciarono a disertare in massa il Circolo del cinema; l’Aula magna del Liceo non ci fu più concessa per le proiezioni; Alberto, il più giovane del gruppo, fu diffidato dai suoi genitori a frequentarci; Rinaldo, impegnato in un’ennesima burrascosa storia sentimentale, cominciò a saltare gli appuntamenti; ed io piangevo sempre più miseria. Senza alcuna ragione plausibile non mi fu più rinnovata la supplenza che mi era stata data al liceo, e la Gazzetta, con scuse risibili, non mi pubblicò più gli articoli che scrivevo per la terza pagina. Quanto a Natalino, che da qualche tempo aveva avviato un’operosissima attività di grafico pubblicitario, nella quale ovviamente era bravissimo, per improvvisa mancanza di clienti, si vide costretto a chiudere lo studio e a tentare la fortuna in altri lidi.
Fu il primo del gruppo dei “giacobini” a partire per il nord.
Lo trovammo una sera, nella stanzetta di Via Cavour che avevamo affittato per la sede del circolo, steso su un tavolo e immobile come un sasso. Capimmo subito che non si trattava di una delle sue solite crisi di malin-conia, ma riuscimmo a farlo parlare soltanto dopo alcune ore. Aveva deciso di partire.
Così l’indomani, rompendo ogni indugio e non curandomi delle perplessità e delle remore di Alberto e Rinaldo, io mi iscrissi al partito.
Poi partecipai ad un congresso provinciale del partito e, di lì a qualche giorno, non fui capace di dire di no all’invito di Alfredo Reichlin a lavorare a Bari nella redazione di un quindicinale di intervento politico-culturale da lui appena fondato.
Reichlin, conclusa la sua esperienza di direttore de “L’Unità”, era stato mandato in Puglia a dirigere il partito.
Aveva un modo intrigante di esprimersi. Ti guardava negli occhi, univa le mani - sembravano d’alabastro - come se pregasse e, spezzando le sue frasi con pause studiate, parlava con voce monocorde ma suadente.
”Ecco, così bisogna muoversi - concludeva immancabilmente - e tutto si scioglierà come neve al sole.”
La metafora della neve e del sole, tuttavia, riuscii a sopportarla non più di un paio di mesi, perché sballottato, controvoglia, da una parte all’altra della città a intervistare dirigenti del PCI barese sui complicati problemi urbanistici del capoluogo pugliese, decisi di lasciare il giornale e di tor-narmene alle mie occupazioni letterarie. Non prima però di assistere ad una scena di cui ancora oggi conservo un vivo ricordo.
Ormai sfiniti per il caldo torrido di quell’estate, siamo dunque riuniti in una stanzetta della Federazione di Via Trevisani a Bari, io Papapietro Pala-sciano e forse Valentino Parlato anche lui a quel tempo mandato dalla Direzione del partito a lavorare in Puglia, e Alfredo Reichlin, con la solita eloquenza, ci sta indicando la strada maestra per “le magnifiche sorti e progressive” del Mezzogiorno d’Italia. Quand’ecco che sulla porta spalancata con forza appare la figura bella altera e furente di Luciana Castellina che, rivolgendosi a Reichlin, a quel tempo ancora suo marito, lo apostrofa così:
“Sei sempre uno stronzo!”
Lo stupore è
generale, Reichlin è visibilmente impacciato, noi fingiamo
di-sinvoltura, ma intanto il mito è dissacrato e tutte le
cattedrali d’idee, i grandi progetti per il riscatto delle
plebi meridionali e per un nuovo ruolo del ceto medio della
città e della campagna si sono miseramente
liquefatti… come neve al sole.
Tra i tanti altri personaggi, politici letterati artisti, che mi capitò di incontrare in quegli anni, Pier Paolo Pasolini fu certamente quello che mi colpì di più.
All’epoca egli lavorava al “Vangelo secondo Matteo”, e alcune scene del film aveva deciso di girarle nel Castello Svevo di Barletta..
Io sapevo quasi a memoria i suoi libri di poesia e spesso de “La religione del mio tempo”, o de “La poesia in forma di rosa”, uscito in quei giorni da Garzanti, recitavo alcuni versi agli amici.
“Madri servili, abituate da secoli/ a chinare senza amore la testa,/ a trasmettere al loro feto/ l’antico vergognoso segreto/ d’accontentarsi dei resti della festa./ Madri servili, che vi hanno insegnato/ come il servo può essere felice/ odiando chi è, come lui, legato,/ come può essere, tradendo, beato/ e sicuro, facendo ciò che non dice…”
Che risposta a certi letterati che allora cominciavano a ritenere che l’im-pegno fosse solo nel linguaggio e non nella tematica! Che forza in questi versi! Che violenza insolita! E che fervore di rivolta contro fenomeni sentiti come odiosi dall’interno di una vicenda nobilissima!…
Che era poi anche la nostra vicenda, dura ma sacrosanta, faticosa ma esaltante.
Così una sera, Rinaldo ed io, decidemmo di partecipare alla conferenza sui rapporti tra cinema e letteratura che, su invito del locale circolo univer-sitario, il poeta e regista era stato invitato a tenere nella biblioteca comunale di Barletta.
La conferenza però purtroppo non ci fu, perché Pasolini, forse interpretando le intenzioni del pubblico, visibilmente eccitato per l’occasione insolita, pre-ferì aprire subito il dibattito, il quale, a parte un paio di interventi re-sponsabili (quello mio e quello di Rinaldo), fu lo spettacolo più deprimente a cui ci capitò di assistere in quegli anni.
In un clima di caccia alle streghe Pasolini fu letteralmente aggredito da insulti grossolani e volgari, meccanicamente ricalcati sulle tesi medievali che fascisti e codini di ogni risma allora facevano circolare sulla sua opera, e ancora più grotteschi perché pronunciati da chi, mentre si ergevano a paladini della morale e della religione, mostravano di non aver mai letto un suo libro e di non aver mai visto un suo film.
Rinaldo ed io ce ne tornammo a casa animati da sacro sdegno, e tanto più mostruoso ci sembrava quello spettacolo, quanto più disarmante, da agnello sacrificale, era stato il comportamento del poeta bolognese per la sua gen-tilezza di modi, per i suoi toni dimessi, per la grande civiltà del suo essere. Si era dato in pasto ai leoni, e i leoni, pur divorandolo, avevano finito con l’esaltarne l’innocenza.
Su quella serata scrissi poi un articolo che Pasolini lesse a Matera, dove ter-minò le riprese del suo Vangelo.
Ne fu molto contento e volle assolutamente farmelo sapere.
Quando fu ferocemente ucciso nella notte fra il 1° e il 2 novembre del 1975, mi ricordai di quella sua serata barlettana e della sua disperata vocazione al martirio e, l’indomani, ne parlai ai miei ragazzi in classe.
Fu quella, forse, una delle mie più belle lezioni di letteratura e di vita.
Per via della guerra sono rimasto orfano di madre a nove anni, e con mio padre, un brav’uomo indubbiamente, un artigiano di vecchio stampo, quando ci siamo parlati non sono mai riuscito a farlo andare al di là di un “ehm” o di un “uhm”.
Da ragazzo si era messo a costruire carrozze, ed aveva tentato la fortuna persino a Modena e a Salerno.
Per quanto abbia capito di lui, a me riesce difficile pensarlo capace di stare anche solo per un giorno fuori di casa. Eppure è andata così.
Tornato a Trani, il 1924 aveva sposato la donna con cui avrebbe messo al mondo sei figli, ed aveva aperto bottega, dalla quale, nei tempi d’oro, erano usciti i landau, i break, i tonneau, le coupé dorsay, i dos-a-dos pour dame, stupende carrozze che, volta per volta, gli erano state commissionate dai signori del luogo e che ancora oggi sono conservate nell’apposito museo di Piazza Quercia a Trani.
Poi, con la diffusione sempre più massiccia dell’auto, nei primi anni trenta, gli affari erano cominciati ad andar male.
“A me mi ha fregato l’automobile!” era solito dire nei rari momenti in cui gli veniva voglia di parlare della sua giovinezza, e, con l’incubo di una fa-miglia numerosa da sfamare, aveva pensato di cambiare attività.
Dopo aver superato una specie di concorso di ammissione nel ’35, infatti, era stato assunto, come dipendente civile, dal Genio Militare allora di stan-za a Trani.
Aveva dovuto però aspettare un anno prima di prendere servizio, perché, pur vincitore di concorso, gli era stato preferito un tale che, per nulla refrattario come lui ad una tessera di partito, risultava regolarmente iscritto al fascio.
Quel tale tuttavia, già ammalato da tempo, entro pochi mesi morì e mio padre, per mancanza di altri concorrenti, ebbe finalmente il posto che gli spettava di diritto.
Era stato quello il suo primo impatto con il regime.
Il secondo, mi ha poi raccontato, lo ebbe in occasione di una delle tante pa-rate che, negli anni Trenta, si organizzavano in città per il “sabato fascista”.
Lui, naturalmente, non partecipava mai a queste parate, però, da curioso qual era, con il suo immancabile borsalino a larghe tese non mancava di scendere in strada al passaggio di un corteo o per una sfilata marziale.
“Ehi tu! Togliti il cappello quando passiamo noi! - lo apostrofò un giorno, a-gitandogli il manganello sotto il naso, una di quelle “giovani italiane” che procedendo ai lati del corteo fungevano da servizio d’ordine.
“Hai capito - aggiungeva indignato ogni volta che, ricordandogli io quell’e-pisodio, cercavo di capire come lui avesse reagito - Quella grande troia vo-leva che io mi togliessi il cappello!”
“Ma tu il cappello te lo togliesti?” ho continuato a chiedergli per anni, e poiché immancabilmente si finiva col parlare d’altro, per anni mi è piaciuto immaginare mio padre resistere con fierezza all’intimidazione del fascio e tenersi in testa il suo bel cappello.
E lui, sornione, mi ha lasciato fare. Fino agli ultimi giorni di vita, quando, coprendosi con la mano la bocca ormai sdentata (in verità non c’è mai stato verso di fargli usare la dentiera) e soffocando la sua solita mezza risatina, mi ha confessato:
“Ma come facevo a non togliermelo il cappello. Quella grande troia me l’a-vrebbe suonato in testa il suo manganello!”
Povero papà, morì a settantanove anni, con il cruccio di essere stato fregato dall’automobile e con l’orgoglio di vedere, lui che a stento aveva fatto le elementari, i suoi figli “istruiti” e, come nel mio caso, persino impegnati politicamente.
Non che condividesse fino in fondo la mia militanza, le mie idee, che in ve-rità gli sembravano “un po’ esagerate”, ma non c’era un mio comizio, non c’era un mio intervento pubblico che non lo vedesse discreto e tacito spettatore. Io parlavo, parlavo, parlavo e sapevo che dietro quella colonna, dietro quell’albero, c’era mio padre ad ascoltarmi e, chissà, a sussurrare all’orecchio del vicino. “Quello è mio figlio!”
Nell’estate del ’43 mio zio Rodolfo faceva il servizio militare a Barletta ma, poiché s’era fidanzato con la figlia del comandante della caserma, gli era facile venire spesso a Trani, naturalmente con grande gioia di mia madre, ch’era sua sorella, e di tutti noi ragazzini affascinati dalla sua divisa gri-gioverde e incuriositi da quelle strane fasce che gli avvolgevano le caviglie e i polpacci e che lui, riavvolgendole con cura meticolosa, srotolava non appena entrava in casa.
Negli ultimi tempi, tuttavia, le sue visite, per i racconti di guerra che puntualmente egli ci faceva, più che provocare la festa in casa ci mettevano addosso un’inquietudine strana.
La guerra, infatti, anche a Trani l’avevamo toccata con mano: il 27 aprile, Lunedì di Pasqua, aerei inglesi avevano lanciato bombe al porto e alle ca-sermette provocando la morte di 21 civili e 14 militari.
Ricordo benissimo quella notte.
Casa nostra era molto vicina al porto e quando le bombe cominciarono a cadere le sentimmo fortissimo dal sottoscala che s’affacciava nell’androne, che i miei avevano adibito a rifugio e nel quale ci eravamo rinchiusi appena suonò l’allarme.
L’indomani mattina racconti terribili giunsero dal luogo del disastro.
Ci raccontarono di case crollate, di laghi di sangue, di corpi martoriati.
Un mio coetaneo mi disse persino di aver sentito di un tale che, sorpreso dal bombardamento in bicicletta, continuò a pedalare per un lungo tratto di strada nonostante uno spezzone di bomba gli avesse tranciato di netto la testa.
“Ti giuro - mi disse serissimo in cambio di un album di Dick Fulmine - A te non posso raccontare bugie…”
Perché non credergli, ma dovevo rifarmi: anch’io avevo il diritto di raccontargli qualcosa di eccezionale.
E fui davvero fortunato. Salito qualche giorno dopo sul terrazzo di casa per recuperare una tartaruga che nel trambusto generale avevamo lì dimenticata, trovai una grossa scheggia di bomba che, trionfante, consegnai a mio padre.
E lui, che con le mani sapeva creare cose bellissime, a differenza di me rimasto in proposito sempre un po’ maldestro, ne ricavò un posacenere che per anni ha troneggiato su un tavolino rotondo di ciliegio che faceva mostra di sé in un angolo del salotto di casa.
L’amico che mi parlò dell’uomo in bicicletta fu costretto a privarsi di ben due album di Mandrake per poter toccare quella scheggia.
Dopo quel bombardamento, per la paura che prese un po’ tutti, in città cominciò la corsa allo “sfollamento”, che il governo fascista, d’altra parte, raccomandava molto vivamente insieme ad una campagna denigratoria nei confronti degli “alleati” anglo-americani, dipinti peggio del diavolo.
Pertanto, chi poteva permetterselo se ne andò nella sua bella villa in cam-pagna, gli altri s’arrangiarono alla meglio.
La mia famiglia, che una villa non l’aveva, trovò ospitalità, insieme ad alcuni zii e cugini, in una grande masseria della bassa Murgia, con grande felicità di noi ragazzi (io, mio fratello Gaetano e i miei cugini Andrea e Michelino) che, lontani dalla scuola, di cui si era disposta la chiusura anticipata, avevamo finalmente la libertà di andare per campi a caccia di lucertole, di arrampicarci sugli alberi e di prenderci qualche volta a sassate.
E fu per un sasso da me scagliato contro Michelino, con mia intima soddi-sfazione andato a segno ma per nulla tollerato dai miei zii, che la già diffi-cile convivenza tra i numerosi occupanti della masseria fu ritenuta, da mia madre soprattutto, assolutamente non più sostenibile.
Così ce ne rientrammo in città, dove intanto, per il suo lavoro al Genio militare, mio padre era stato costretto a trattenersi, e in città, da Barletta, potè tornare a farci periodicamente visita lo zio Rodolfo.
Non credo che lo zio Rodolfo fosse un fascista convinto, ma parlava parlava parlava, e soprattutto, millantando una conoscenza profonda dell’andamento della guerra ed eseguendo acriticamente le direttive del governo, giorno dopo giorno ci assillava con notizie e con messaggi sempre più allarmanti.
“Arrivano i nemici!… Ci faranno fuori tutti!… Bisogna scappare…Bisogna scappare!… Fate i bagagli e andate tutti al Nord…”
E quando i “nemici”, ossia gli anglo-americani, arrivarono davvero, ossia sbarcarono in Sicilia, andando ben oltre il “bagnasciuga” sul quale Mussolini aveva solennemente promesso che li avrebbe lasciati “in posizione orizzontale”, apriti cielo: la paura diventò panico, e mia madre, con grande disappunto di mio padre che tuttavia come al solito non aprì bocca, si persuase che davvero era venuto il momento di abbandonare Trani.
E, destinazione Porretta Terme, partimmo. Non prima però di essermi sen-tito per la prima volta fieramente antifascista.
Quando, infatti, il 25 luglio alla radio sentimmo la notizia della caduta di Mussolini, dimenticai d’un tratto le lacrime che appena alcuni giorni prima avevo copiosamente versato perché i miei non mi avevano ancora comprato la divisa di “figlio della lupa”, presi da un cassetto di mio nonno un grosso medaglione di latta con l’effigie del duce e lo schiacciai con forza sotto i piedi.
Ricordo che fu una notte lunghissima quella del 12 agosto del ’43.
Carichi di bagagli andammo alla stazione in due carrozze distinte: io con mia madre e il nonno; Gaetano e le mie sorelline con mio padre, che dal Ge-nio s’era fatto dare un permesso speciale per poterci accompagnare fino a Porretta.
Sul basolato di Via Cavour, che da casa nostra alla stazione si doveva per-correre interamente, gli zoccoli dei cavalli facevano un rumore secco e insistente, amplificato dal silenzio della notte e inframmezzato dallo schioc-co della frusta che i vetturini facevano ruotare sopra il capo.
A me piaceva moltissimo andare in carrozza. Con la carrozza ci si recava al cimitèro o alla stazione, e qualche volta, se pioveva, anche a scuola. Mi piaceva il suo forte odore di legno e di cuoio, e se qualche volta mi capitava l’avventura di sedermi a cassetta, accanto al cocchiere, mi sentivo più felice che mai.
Dall’alto del mio scanno guardavo allora le frotte di ragazzini che, imman-cabilmente, al passaggio di ogni carrozza, le correvano dietro gridando a piena voce: “Tro…je, tro…je…”, finché un altro minaccioso schiocco di frusta non le disperdeva, ma temporaneamente.
Non ho mai capito che cosa significasse quella parola, e le diverse scuole di pensiero fiorite in proposito a tutt'oggi non ne hanno ancora dato un’inter-pretazione attendibile, né, credo, potranno darla in futuro, considerato che, a Trani, di carrozze non ne circolano più ormai.
Mi piaceva moltissimo, dunque, andare in carrozza, ma quella notte il legno dei sedili era durissimo, l’odore del cuoio e il calpestio dei cavalli insopportabili, e lo schiocco della frusta dei due vetturini mi faceva rabbrividire.
Ricordo che, per tutta la durata del viaggio, non chiusi occhi, né feci dormire i miei, perché, ossessionato dal tempo che mi pareva non passasse mai, ad ogni stazione chiedevo, petulante, l’ora.
A Bologna prendemmo la coincidenza per Porretta, dove subito ci recammo al Collegio “Albergati” dei padri barnabiti.
Si era deciso che io e mio fratello Gaetano avremmo frequentato qui il pros-simo anno scolastico; le mie sorelline, accompagnate dal nonno, avrebbero proseguito per Portacomaro d’Asti, dove già da qualche mese era sfollata la famiglia di una zia; e mia madre, che già non stava bene, per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici si sarebbe fermata per qualche giorno in ospedale a Bologna, e di qui poi avrebbe raggiunto la sorella e le figlie in Piemonte.
Quanto a mio padre, per motivi di lavoro, già l’indomani ripartì per Trani.
Da adulto, ogni volta che ho ripensato a quegli anni, non sono mai riuscito a capacitarmi delle decisioni prese allora, dell’assurdità di quello smem-bramento di un’intera famiglia, della follia di aver preferito al proprio paese dove, sia pure nel pericolo, si poteva avere il conforto di parenti e amici, località lontane, sconosciute, e che poi si sarebbero rivelate ancora più insi-cure e più esposte ai rischi di quanto ciascuno poteva immaginare.
Eppure andò proprio così. La guerra fu anche questo, a dispetto di ogni lo-gica e del buon senso.
La sera dell’8 settembre, pensando che la guerra fosse finita, ci fu festa grande al Collegio “Albergati”. Si accesero anche i falò e i padri, per distrarmi dai miei crucci, mi chiesero di cantare l’”Ave Maria” di Schubert, della quale alcuni giorni prima avevo imparato le parole.
Lo feci con tanto impegno che alla fine mi applaudirono tutti.
Ne fui davvero contento e quella notte, per la prima volta da quando ci ave-va lasciati, non pensai a mia madre.
Poi, il giorno dopo, ci dissero che i tedeschi avevano catturato dei soldati italiani nella caserma e che, dopo averli costretti a salire sui camion, li avevano portati via, verso il nord disse qualcuno, in Germania disse qualche altro.
La guerra insomma non era finita, anzi ne cominciava un’altra, che durò lunghi mesi e che per me fu soprattutto l’urlo agghiacciante delle sirene, i minacciosi stormi di aerei che oscuravano il cielo, lo strazio dei feriti dopo i bombardamenti, una corsa affannosa per la campagna emiliana sotto le raffiche di mitraglia sparate da un aereo a volo radente, il passo marziale dei soldati nazisti ingigantito come uno schiacciasassi nella memoria di un bambino di nove anni, i repubblichini di Salò che, ferocissimi, se ne anda-vano in giro a caccia di partigiani.
Soltanto dei flash, delle illuminazioni improvvise nel buio di tutto il resto, di quella nostra permanenza a Porretta, lontani da parenti e da amici.
Certo, i padri erano buoni, ed io e Gaetano conoscemmo altri ragazzi, come i due fratelli Soldano, per esempio, anch’essi pugliesi, e quel Croce, un ragazzo di sedici anni, un fanatico che parlava sempre di banditi e di vendette, che scappò via dal collegio per andare a combattere coi fascisti e che poi fu trovato morto con un buco in fronte.
Ma vivevo in attesa non so di che cosa e i giorni passavano senza tempo.
Poi, l’8 febbraio del ’44, arrivò la notizia.
Ce la portò Francesco, l’altro mio fratello, di dieci anni più grande di me, che studiava a Firenze e che a casa volevano si facesse prete.
Fu lui a dirci che mamma era morta il 25 gennaio.
A Gaetano, che era a letto per un’influenza, la sera la febbre salì alta e poi vomitò.
Io non sentii nemmeno più il dolore ai geloni che, coi primi freddi, mi ave-vano trasformato le mani in panzarotti rosa.
E non mi ricordo di aver pianto, ma so che feci piangere quelli che mi erano vicini.
Quando non avevo nulla da fare, io scendevo volentieri nella cucina del collegio, che era un ampio locale dello scantinato con le pareti ricoperte da piastrelle di ceramica bianche con fiorellini blu e tanti tegami e pentole di rame appesi ai loro chiodi.
Le suore cuciniere, allegre e chiacchierone, mi avevano preso a benvolere e mi lasciavano curiosare liberamente tra i fornelli sempre accesi.
Non che vi fosse tanto da mangiare e fosse molto varia la qualità del cibo che si preparava per il pranzo e per la cena, ma a me andava bene tutto ciò che usciva da quella cucina, e poi mi piaceva la polenta, ed era uno spetta-colo vederla scodellare, fumante gialla e pastosa, dal paiolo di rame sulla lastra di marmo che ricopriva il grande tavolo troneggiante al centro dello stanzone, e davvero mi faceva venire l’acquolina in bocca vederla poi condire con salsa di pomodoro e formaggio e, a volte, persino con della salsiccia cucinata in un soffritto di cipolla carota e sedano.
Ma dopo alcune settimane, per via della guerra, di salsiccia non se ne vide più nemmeno un rocchio, e anche le ultime galline del pollaio finirono fatte a brodo.
E con la polenta, ormai servita senza intingoli e condimenti saporiti, co-minciarono ad abbondare invece, fino a rendermeli disgustosi, castagnacci, mele e cachi.
Finché a Pasqua, d’improvviso, la grande novità.
Scendo, infatti, in cucina per curiosare come al solito ed ecco le suore annunciarmi, giulive, che a pranzo avremmo mangiato del coniglio.
Ritorno di corsa da Gaetano e dai fratelli Soldano e comunico loro la lieta novella.
“Oggi è Pasqua e si mangia carne!”
Mi guardano scettici e poi, come se non ci fossi, continuano a tirare calci al pallone.
Ma quando a pranzo arriva davvero il coniglio, mi prendo la mia rivincita e dico trionfante:
“E adesso ci credete? Non dovreste proprio mangiarlo, adesso!”
E quelli, senza indugio, mi danno la loro porzione.
Ne mangio ancora, un po’ di qua e un po’ di là, e poi Gaetano, mentre i due Soldano cominciano a ridere, mi dice:
“Ma non hai visto che non ci sono più i due gatti nel giardino? Quelle cape di pezza oggi ci hanno passato dei gatti per coniglio!”
Sono stato male tutto il giorno, e ho dovuto vomitare pure l’anima per po-termi sentire un poco meglio.
Poi, se i fratelli Soldano mi sono diventati improvvisamente antipatici, con Gaetano non mi sono più parlato per qualche giorno, fino a quando le suore, venute a conoscenza della sua spiata, hanno cominciato a incattivirsi con lui ed io, ovviamente, ho dovuto schierarmi dalla sua parte.
Quanto alla cucina, infine, naturalmente da allora non sono più sceso a curiosare fra le sue pentole da fattucchiere e, forse generalizzando un po’, ricordando quel pranzo pasquale, da adulto mi è stato sempre difficile prendere le monache sul serio.
Scorreva il fiume Reno dietro il campetto del collegio e spesso, noi ragazzi, se non c’erano partite di calcio da giocare, passavamo il tempo della ricreazione standocene sul greto a fare le scalette con le pietre più levigate o a sfidarci nel guado.
C’era un punto, infatti, in cui saltando su alcuni grossi scogli che emergevano dall’acqua, si poteva passare dall’altra parte del fiume: bastava spiccare il salto giusto, mi dicevano, e guardare diritto davanti a sé.
Ma per me guadare il fiume era un’impresa impossibile: ci rinunciavo puntualmente dopo il faticosissimo primo salto e quelle due e tre volte che cercai di andare avanti finii immancabilmente in acqua, poco profonda, è vero, ma gelida.
Eppure la mattina in cui fu bombardata la stazione di Porretta e i padri decisero che era più sicuro scappare per i campi che restare rintanati nel collegio, lo spavento mi infilò le ali ai piedi e, dopo Gaetano, anch’io in quattro salti mi ritrovai sull’altra sponda del fiume e quindi come una lepre a correre nell’erba alta della valle del Reno, mentre un aereo, volando basso ci sparava addosso raffiche di mitraglia.
“Chi era
l’eroe dei due mondi?”
“Giuseppe Garibaldi.”
“Qual è la capitale d’Italia?”
“Roma, detta ‘caput mundi’.”
“E il fiume più lungo?
“Il Po.”
“Quanto fanno quattro per quattro?”
“Sedici.”
“Qual è il dovere di ogni cittadino
italiano?”
“Credere obbedire e combattere.”
“E chi ci guida verso la vittoria?”
“Il duce del fascismo.”
“Bravo, promosso.”
Giusto il tempo di fare, per così dire, l’esame di terza elementare io e quel-lo di quinta Gaetano, di salutare la signora maestra, di abbracciare i padri, e poi subito sul camion che ci aspettava fuori del collegio per portarci, con Francesco che era venuto a prenderci, a Firenze.
Era un camion militare, di quelli della Repubblica di Salò, e questo, disse l’autista, ci avrebbe fatto viaggiare indisturbati, senza essere fermati ai posti di blocco eventualmente predisposti dai tedeschi lungo la Porrettana.
Ma, naturalmente, accadde tutto il contrario.
Al Passo della Collina, infatti, vicino a Pistoia, eccolo il posto di blocco temuto ed eccolo il nostro autista accelerare improvvisamente, sorpassare la fila di automezzi in attesa del controllo e proseguire velocissimo per la sua strada.
.“State giù, state giù…” ci disse pigiando sui pedali.
Per fortuna i soldati tedeschi erano soltanto due e, impegnati a guardare i documenti ma soprattutto sorpresi da tanto ardire, non ci inseguirono.
Però sentimmo degli spari, secchi, a raffiche.
“State giù, state giù…” ci disse ancora l’autista.
Io, Gaetano e Francesco, accovacciati ai suoi piedi, ci facemmo ancora più piccoli, ma era Francesco quello di noi ad avere più paura.
Ci aveva già raccontato della sua personale esperienza di un bom-bardamento a Firenze, in pieno centro, e di una bomba che, scoppiata vicinissimo a lui, lo aveva lasciato letteralmente senza scarpe e senza cap-pello.
“Ma sei matto? - urlò all’autista - Ci fai ammazzare tutti!”
“Tranquilli, tranquilli… Con la coda dell’occhio ho visto che le moto di quei due figli di puttana hanno le ruote sgonfie… E poi non posso fermarmi: Ho roba che scotta.”
“Sei matto, sei matto” urlò di nuovo Francesco.
Per me, invece, era un eroe e, come nel primo film a colori della mia vita, quello con Errol Flynn, rividi Robin Hood a cavallo nella foresta di Sher-wood contro il tiranno Giovanni senza terra.
“Tranquilli, tranquilli…”
Ma nuovi spari dissolsero il mio Robin Hood e il cavallo bianco, e allora urlai anch’io.
“Tranquilli, tranquilli… Ormai ci siamo” disse di nuovo l’autista.
E davvero c’eravamo, finalmente, lontano dai due tedeschi sì, ma non fuori dal pericolo, perché, in vista di Firenze Peretola, ecco il cielo riempirsi di aerei, e bombe dopo bombe cadere a grappoli sull’aeroporto e alzare, in un fragore vasto e cupo, enormi colonne di fumo nero.
I tre mesi trascorsi a Firenze non furono per niente più tranquilli.
Io e Gaetano eravamo ospiti della zia Olga, un’amica di famiglia che somi-gliava moltissimo a mia madre e che abitava nel centro storico della città, ma andavamo spesso al “San Paolo”, il collegio dei barnabiti sulla via di Fiesole, dove allora studiava Francesco.
Ci capitava quindi di prendere quasi ogni giorno l’autobus, ma spesso, e senza preavviso, alcune corse saltavano per la tensione che in quei giorni c’era in città e di conseguenza, io e Gaetano, restavamo bloccati al “San Paolo”, dove a volte ci toccava passare anche la notte.
Fu in un pomeriggio di luglio che, in attesa che fosse ripristinata la corsa dell’autobus per il centro, vedemmo entrare una decina di uomini dall’aria molto circospetta.
Accolti cordialmente dal rettore, furono subito accompagnati in alcune stanze del piano superiore, quelle riservate ai padri, e la sera li vedemmo presentarsi a cena vestiti da preti.
Erano ebrei, ci disse più tardi Francesco e, con la raccomandazione di non farne parola con nessuno, aggiunse che quei signori si erano vestiti da preti per sfuggire ai fascisti e ai tedeschi che in città avevano intensificato la cac-cia al giudeo.
All’epoca - avevo nove anni - avevo sì sentito parlare di leggi razziali, e qualcosa mi era stato riferito sulle deportazioni di ebrei in Germania. Come quella volta in cui mio fratello Gaetano mi disse che dalla stazione di Porretta era transitato un treno merci carico di gente, dal quale aveva sentito provenire dei lamenti e dal quale aveva visto lanciar fuori dei biglietti con dei nomi; e che da un passante a cui aveva riferito la cosa si era sentito rispondere che si trattava di deportati e che quindi sarebbe stato meglio non immischiarsi.
Ma ancora mi sfuggiva il segno vivo della tragedia, l’assurdità di quella vicenda, che invece percepii drammaticamente alla vista di quegli uomini, costretti a lasciare le loro case, a cercare disperatamente asilo e a vestirsi da preti per sfuggire ai loro persecutori e per sopravvivere.
Ed ebbi anche coscienza del rischio che correvano i padri nel dare ad essi quella ospitalità e quell’asilo.
“Raus, raus!” disse il soldato tedesco all’autista dell’autobus che era stato bloccato proprio mentre, provenendo da Via dell’Oriuolo, dove abitava zia Olga, stava per imboccare la Fiesolana.
Poi altri due nazisti salirono sul mezzo e parlandosi tra loro cominciarono, per così dire, a passarci in rassegna.
Era quasi vuoto l’autobus quella mattina. Vi era un anziano signore, quattro o cinque donne ed io e Gaetano che, seduti in fondo, alla vista di quei soldati c’eravamo rannicchiati come la mia tartaruga sotto il suo scudo quando andava in letargo.
“Cosa fare soli voi bambini?” disse un tedesco guardandoci in faccia.
Poi, senza aspettare una risposta che né io né Gaetano fummo capaci di dargli, riprese a parlare con il suo camerata che ci lanciò un’occhiata e disse a sua volta parole incomprensibili.
Quando scesero dall’autobus, l’autista riprese il suo posto di guida e, rivoltosi alla donna che gli stava più vicino:
“Stanno cercando il partigiano Lupo; ma col cavolo che lo prendono!…” disse nel più bel fiorentino del mondo.
Quando cadde la granata nell’orto del “San Paolo”, uno di quei signori travestiti da prete, con il quale io e Gaetano avevamo fatto amicizia, ci stava raccontando che lui era un compositore, che la Germania aveva dato al mondo i più grandi musicisti, i più grandi pensatori, e che quindi non si dava pace al pensiero che ormai l’attraversava una follia collettiva.
La granata, con un boato terribile e un grande rumore di vetri rotti, cadde all’improvviso e nessuno seppe da dove fosse stata lanciata.
Cadde proprio vicino al giardiniere Giovanni, che stava raccogliendo i po-modori.
Lo scaraventò contro un muro e lo lasciò in un lago di sangue, senza più le gambe.
Nel frastuono generale lo portarono subito in ospedale, ma non ci fu nulla da fare: il poveretto morì prima che ci arrivasse.
Era buona e gentile zia Olga.
Vedova e con un figlio di tre anni più piccolo di me, somigliava molto a mia madre. E come lei portava i lunghi capelli neri raccolti a toupet.
Anch’essa poi, la sera, quando con la luce spenta per via del coprifuoco ci si tratteneva sulla veranda a prendere il fresco e a fare progetti sul nostro avvenire, metteva sulle spalle uno scialle di cotone a quadratini bianchi e neri, proprio come quello che a Trani avevo visto a volte indosso a mia madre.
Quello scialle era uno dei pochi ricordi, uno dei pochi segni concreti che conservavo di mamma, e per averlo rivisto allora sulle spalle di zia Olga mi è rimasto impresso nella memoria per tutta la vita.
Come ancora oggi ricordo le fette di pane tostato spalmate di miele che la zia ci dava al pomeriggio per merenda. Altro che i castagnacci di Porretta!
Zia Olga è morta qualche anno fa, più che novantenne, ed ho saputo che negli ultimi giorni ha pure chiesto di me e di Gaetano.
Ed io che, dopo quel lontano 1944, non mi sono fatto più vivo con lei, nemmeno con un saluto fuggevole..
Gli uomini travestiti da prete si fermarono in collegio per una settimana, poi un giorno sapemmo che si erano trasferiti altrove.
Ma nel luglio del ‘44, al collegio “San Paolo”, ci furono altri gruppi di persone ad avvicendarsi in quel segreto travestimento, e per fortuna senza particolari conseguenze per nessuno.
Solo una volta i repubblichini vennero a chiedere informazioni su certi strani movimenti segnalati da alcuni vicini. Ma i padri furono molto bravi a convincerli di essere all’oscuro di tutto.
Poi di fascisti in giro non se ne vide più nemmeno uno.
E anche di soldati tedeschi se ne cominciarono a notare molti di meno. Stavano abbandonando Firenze, si disse, e facevano saltare tutti i ponti.
Di tanto in tanto, però, dai sobborghi settentrionali della città, dove si erano attestati, scendevano a gruppi di cinque o sei per perlustrazioni.
Intanto si era diffusa la notizia che gli inglesi erano già al di là dell’Arno e che presto sarebbero arrivati da noi.
Ma passavano i giorni e di inglesi non si vedeva neanche l’ombra.
Finché una mattina ci dissero che i tedeschi, in seguito ad una spiata, avevano suonato la campana della Signoria, il segnale convenuto per l’insurrezione, e che alcuni partigiani, caduti nella trappola, avevano perso la vita e che i loro corpi erano rimasti qua e là abbandonati nelle strade.
Un partigiano morto, un siciliano, fu pure trovato in Via della Piazzola, a due passi dal collegio, e nel tardo pomeriggio si provvide a seppellirlo nell’orto del “San Paolo”.
Fummo davvero in tanti a rendergli omaggio.
Mi trovavo davanti al cancello d’ingresso del collegio quando vidi avanzare in due file distinte ai bordi della strada, uno dietro l’altro, degli uomini armati chi col mitra e chi col fucile.
Portavano al collo un fazzoletto rosso, ma c’erano anche alcuni col fazzo-letto azzurro.
I partigiani, pensai, e cominciai a salutarli con entrambe le mani.
Quelli mi risposero e quando furono vicini a me gridai con tutto il fiato che avevo in corpo.
“Di là, di là… I tedeschi se ne sono andati di là!”
“Bravo ragazzo… Ma adesso vattene dentro. Qui tra poco ci sarà un po’ di casino…” disse l’uomo che andava avanti a tutti.
Ed io corsi dentro a dare la notizia, e intanto non stavo più nella pelle: anch’io avevo dato una mano all’insurrezione, che era quella vera, final-mente.
Quando qualche giorno dopo arrivarono gli inglesi, tutti scesero per le strade a far festa, tutti applaudirono gli alleati.
E in quella folla, avvicinando ora questo ora quel soldato, c’ero anch’io a parlare in inglese per la prima volta nella mia vita:
“Give me some chocolate... Give me some bread...”
Ed anche il viaggio di ritorno a Trani fu un’avventura.
L’ultima notte a Firenze la trascorremmo al “San Paolo”, per cui il giorno prima, tra le lacrime di tutti, ci accomiatammo da zia Olga.
Era ancora l’alba quando uscimmo dal collegio e, a piedi, da Via della Piazzola, attraversammo con Francesco tutta la città ancora deserta, pas-sammo il Ponte vecchio, l’unico che i nazisti non avevano distrutto, ma ancora in parte ostruito, in capo e in coda, da cumuli di macerie, e ci fer-mammo di fronte a Palazzo Pitti, dove era stato fissato l’appuntamento.
Un ufficiale inglese, che per alcuni giorni si era fermato ospite al collegio, si era offerto di accompagnarci in camion fino a Roma e di lì poi, con altri mezzi, avremmo proseguito per Trani.
Lui a Roma, aveva detto, doveva andarci comunque e perciò non era un pro-blema darci un passaggio.
Ma in Piazza de’ Pitti quella mattina non c’era nessuno ad aspettarci. E solo dopo un’attesa che durò un’eternità, da Via de’ Guicciardini vedemmo spuntare un camion inglese, che venne a fermarsi proprio davanti a noi. E un caporale, con il suo elmo a padella sul capo, dopo averci chiesto se eravamo quelli dell’appuntamento, disse che l’ufficiale purtroppo era stato mandato altrove.
“No problem, of course… Tutto molto bene” aggiunse mescolando al suo inglese un italiano appena imparato.
Volendo, a Roma potevamo andare con lui, pur facendo una strada diversa.
E noi, non sapendo che altro fare, salimmo sul camion.
E così, superata Arezzo, ci ritrovammo, io e i miei fratelli, nientemeno che a Castiglion Fiorentino, in un affollato campo profughi amministrato dagli alleati, e dove per alcuni giorni ci toccò dormire in una grande tenda, fare lunghe code per le nostre razioni quotidiane di latte in polvere, di carne in scatola e di uno strano pane bianco e soffice, e sottoporci a una visita medica che, per tutti, si concluse inevitabilmente con il taglio totale dei capelli e una spruzzata di insetticidi vari per tutto il corpo.
Poi accadde che Francesco si ammalò, forse di malaria. Ebbe anche febbre alta, e cominciò a smaniare.
Ma io e Gaetano non ci perdemmo d’animo, chiamammo un medico del campo e quello, dopo averlo palpato ben bene, gli dette del chinino, e in un paio di giorni, per fortuna, la febbre, così com’era venuta, improvvisamente passò.
Riuscimmo a resistere più di una settimana in quel campo, finché una mattina decidemmo di svignarcela e, attraverso una siepe, uscimmo sulla strada.
Era la provinciale per Cortona e parallela alla strada, a un centinaio di me-tri, correva la ferrovia.
Quando la tradotta, sbuffando, si fermò proprio davanti a noi, pensammo che l’unica cosa da fare era quella di salire su un vagone.
Poi la tradotta ripartì, lentamente, e noi, sdraiati sull’assito, già pregustava-mo un viaggio tranquillo per Roma.
Ma d’un tratto lo sportellone, che per prudenza avevamo pensato di richiudere, fu fragorosamente riaperto, e un sergente inglese, in bermuda e con uno staffile in mano, saltò nel vagone e si sedette anch’egli per terra, lasciando tuttavia le gambe penzoloni nel vuoto.
Facemmo tutto il viaggio senza parlare, angosciati da mille terribili pensie-ri e con gli occhi fissi sulla sua faccia indecifrabile, sulle sue gambe nude che ciondolavano ad ogni sobbalzo della tradotta, e soprattutto su quella frusta che di tanto in tanto ci sembrava egli facesse roteare sulla testa.
Soltanto alla stazione di Cortona, dove lui scese, ci guardò e, dopo averci sorriso, disse:
“ Ciao, italiani…”
Passarono altri mesi prima che la famiglia, o meglio quello che restava della famiglia, si ricongiungesse.
Le mie sorelle, infatti, da Portacomaro tornarono a Trani soltanto alla fine del ’45 e, naturalmente, anch’esse con le loro storie di guerra da rimuovere o da ricordare per tutta una vita.
Mio padre intanto s’era fatto più taciturno e, alle prese con problemi di cui si era occupata sempre mia madre, si smarrì e praticamente ci lasciò cre-scere da soli.
Ora non è importante dire se, per quanto mi riguarda, me la sono cavata o no, cosa che, d’altra parte, chiunque può capire da solo.
Conta invece affermare che,
pur non sapendo ancora l’uso che ne farò nel mio
romanzo, a me tocca il compito di dare una voce a questi ricordi che,
come acqua dalla sorgente, ormai sgorgano prepotenti dalla mia mente.
* "Renato e i Giacobini", Palomar, Bari 2006.